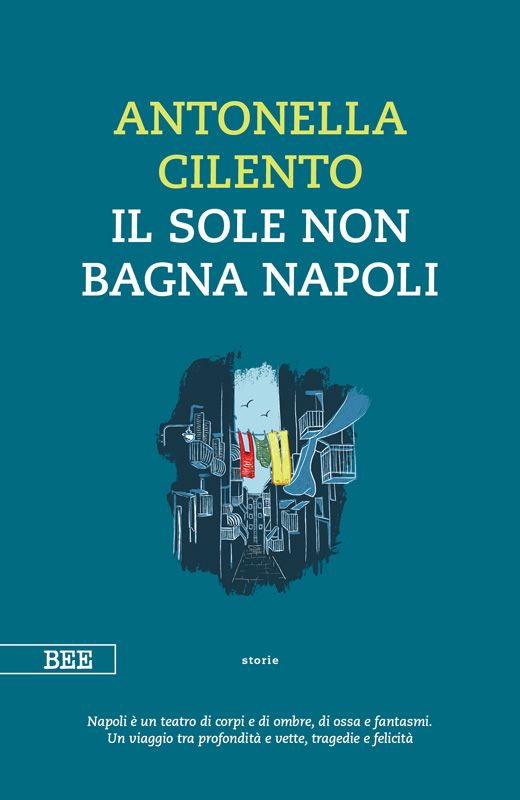Sarajevo nel cuore di Bottega
4 Aprile 2024
Capire il confine: Giustina Selvelli racconta Gorizia e Nova Gorica
17 Aprile 2024Il sole non bagna Napoli
Antonella Cilento racconta il suo nuovo libro in dialogo con Erika Milite
Un reportage narrativo da Napoli, città di occhi, ossa, balconi, guerra
Il sole non bagna Napoli è il titolo del nuovo libro di Antonella Cilento, che per i lettori di Bottega Errante, ha dialogato con Erika Milite, ufficio stampa della casa editrice, sulla scrittura, sulla città e le sue voci, la vita tra le ombre di Napoli e nel sottosuolo, gli strati che questa straordinaria città accumula uno sopra l’altro, senza sosta, da centinaia di anni. Buona lettura!
Leggendo il manoscritto de Il sole non bagna Napoli c’è una frase che mi ha colpito. “La bellezza, anche molto oltraggiata, è davvero dura a distruggersi”. Quali sono le forme in cui la bellezza resiste a Napoli?
Una colonna romana compare all’angolo di un vicolo dell’Anticaglia, incastrata fra un basso, un manifesto stracciato e, se la osservo di notte, ho come l’impressione che il passato sia vivo e stia emergendo, meraviglioso e fantastico, fra chiese barocche, angeli che volano al buio come gabbiani, santi che chiacchierano dalle nicchie dei conventi: questa, forse, è la bellezza che più mi sorprende e mi conquista di Napoli, insieme al perfetto cielo azzurro, all’impressione di essere inclusa in un quadro di paradiso. L’impressione di abitare in una scatola magica, in un contenitore infinito di storie che ad ogni angolo pietre e persone, volti, maschere, voci, parole e immagini moltiplicano. Una luce, un profumo, un’apparizione: qui non si butta mai niente ed è come se addirittura il passato rinascesse, si reincarnasse all’insaputa degli abitanti. Il modo in cui una banchina in disuso s’inoltra in mare. Gli strati di epoche non isolati dal presente: un arco catalano con dentro un infisso d’alluminio, un bando vicereale sopra un’officina d’elettrauto. Tutto è insieme antico, consumato, presente, più nuovo del nuovo. La bellezza a Napoli è una antichissima, resistente forma di visione, che scaturisce a dispetto di chi la attraversa: per questo addolora tanto vedere lo spreco, la distruzione, la trascuratezza in un luogo così tanto carico di bellezza da essere proverbiale da millenni.
Ci sono delle parole che per te definisco e conducono la tua narrazione su Napoli: occhi, ossa, balconi, guerra. Perché hai scelto proprio queste?
Gli occhi hanno una lunga tradizione nel Mediterraneo: sono simulacro di protezione (l’occhio di vetro azzurro che ancora si acquista come gadget in Grecia e che si dipingeva sulle prue delle navi antiche) ma sono anche tramite di maledizioni: la jettatura è l’occhio gettato, lo sguardo che proietta l’evento negativo a danno di qualcuno. Quando ho iniziato a scrivere Il sole non bagna Napoli avevo appena avuto un distacco di retina prontamente operato: non poter vedere più la sfera perfetta del cielo e del mare e tutte le imperfezioni della città è stata una sorpresa. E così tutti gli occhi, quelli di vetro osservati da Sartre nel suo viaggio a Napoli, quelli delle madonne, quelli narrati in letteratura sono diventati subito un tema che si lega alla grande presenza delle ossa nell’immaginario della nostra città (dal celebre Cimitero delle Fontanelle alle numerose catacombe, dalle terre sante nelle chiese alle sepolture ospedaliere, Napoli è una città costruita sulle ossa) e a tutti i balconi che la città ospita, da quelli antichi, come l’affaccio del Quarto del Priore dalla Certosa di San Martino ai balconi proliferati su Posillipo con l’abusivismo edilizio del dopoguerra. E quindi anche la guerra, che è in fondo una delle anime di Napoli, dove tutto è conflitto, i segni della seconda guerra mondiale sono ancora visibili, le guerre di camorra sono l’ultima frontiera in una città conquistata, governata, colonizzata da sempre. L’immagine di Guernica di Picasso, conservata in una stanza della mia casa d’origine, è in questo libro una delle soglie dai cui narrare il Vomero, gli strati dell’architettura fascista che fondano la città nuova, la città ricostruita, la bruttezza anche delle forme architettoniche moderne che formano la nostra identità da numerose generazioni. Occhi, balconi, ossa, guerra sono alcune delle tracce che narrano, quindi, una Napoli meno ovvia, meno oleografica, non fissata dai media.
Rispetto agli altri libri che hai dedicato a Napoli in che cosa si differenzia Il sole non bagna Napoli?
In quasi tre decenni di libri Napoli è stata il fondale o la causa di quasi tutti i miei romanzi e la protagonista di alcuni libri dedicati alla sua storia, alla sua immagine, al suo corpo narrabile, raccontabile. Ho narrato Napoli attraverso i quattro elementi, sotto forma di bestiario, esplorando le deformazioni del suo mondo culturale, descrivendo i suoi confini, ad esempio la Foresta di Cuma.
Il sole non bagna Napoli è fra tutti questi il libro più atipico, poiché raccoglie suggestioni che riguardano i bordi della città, più che il suo centro più visibile o famoso, benché Napoli sfugga sempre ad una descrizione totale: il terzo decumano del centro antico, l’Anticaglia, è per esempio oscurato rispetto a via dei Tribunali e a via san Biagio dei Librai. Oppure: tutti conoscono lo sky line della città, il suo lungomare ma pochi visitano il molo di Bagnoli. Lunghe file precedono l’ingresso di Cappella Sansevero ma quasi nessuno conosce la storia di Nisida. Quanti visitano il Museo Nitsch o gli ipogei ellenistici e quanti vanno al MANN, al Museo Archeologico Nazionale? Da sempre, mi pare di osservare e vedere e cercare quel che agli occhi dei più sfugge, pur essendo esposto giorno e notte. Il titolo del libro, omaggio a Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, nasce anche da altre suggestioni, un fantomatico libro che narra un tragitto per percorrere Napoli senza restare mai al sole tramandato da numerosi scrittori e studiosi: tuttavia, davvero questa città della luce e del sole in realtà dal sole è poco bagnata, non solo per l’oscurità dei suoi vicoli ma perché mai guardata con completezza, nella sua straordinaria complessità, ma solo per luoghi comuni, tòpoi, favolette e favolacce…
Se ami i reportage narrativi, ti consigliamo queste letture:
-
E Lisbona sfavillava di Tino Mantarro: un mosaico urbano in forma di reportage.
-
Roma dal bordo di Loredana Lipperini: una geografia sentimentale della città scritta da chi la guarda con stupore e disincanto.
Napoli è una città che ha avuto tante voci nella letteratura. Quello che mi piace notare è che sono spesso voci femminili o personaggi femminili. Penso a Fabrizia Ramondino, Anna Maria Ortese, Matilde Serao. Un caso?
Le voci femminili sono particolarmente autorevoli a Napoli, a partire dalla fine dell’Ottocento con Matilde Serao, e sono spesso voci che hanno anche un impegno diretto di natura sociale, oltre che culturale: penso all’impegno di editrice e giornalista di Serao, davvero imponente e impressionante rispetto alla sua epoca, una frontiera di livello mondiale rispetto al lavoro femminile e anche al mondo intellettuale, ma anche all’impegno politico e sociale di Fabrizia Ramondino, come giornalista, attivista, operatrice sul territorio con l’Associazione Risveglio Napoli, la Mensa Bambini Proletari.
Anche Ortese ebbe un suo peso specifico poiché il capitolo dei Granili ne Il mare non bagna Napoli portò alla demolizione di questo luogo di inquietante povertà della Napoli post-bellica. A mia volta, restando a Napoli trent’anni fa, ho segnato un destino fondando una delle più antiche scuole di scrittura d’Italia, Lalineascritta, da cui provengono molte nuove voci, anche femminili, della nostra editoria e letteratura, lavorando sia nelle realtà scolastiche più periferiche e abbandonate, sia in città, sia fondando un master, SEMA, che è una porta per il lavoro editoriale aperta per la prima volta a Napoli in una visione formativa nazionale. Napoli è femmina, senza dubbio. Nel senso più antico e pericoloso e creativo del termine, dunque che abbondino le scrittrici in questo libro è naturale: sono le mie antenate, sono da sempre i miei riferimenti di scrittura, specie Ortese, che a dieci anni ha segnato il mio destino di narratrice, e Ramondino.
Che cosa succede nel sottosuolo di Napoli?
Molte cose accadono a Napoli sotto il livello del suolo: ci sono acquedotti greci, romani, vicereali, borbonici in larga parte percorribili; ci sono sepolture, neolitiche, ellenistiche, romane, medievali e moderne: ossari, terre sante, catacombe; ci sono metropolitane d’arte; ci sono discariche; ci sono cave greche di tufo, dove il tufo partorisce altro tufo: e anche queste sono visitabili.
C’è un infinito mondo sotterraneo che Napoli conserva da sempre: dagli acquedotti la città può essere invasa, dalle cave e dalle piscine sotto le abitazioni risalgono operai fantasmatici, i monacielli, negli ossari si prega e si adottano teschi che diventano persone di famiglia e spiriti protettori. Dal sottosuolo si fugge, come volevano i Borbone scavando un tunnel che va da Palazzo Reale a Mergellina; ci si rifugia in cave acquedotti e ossari durante i bombardamenti. Da sotto terra si arriva al mare, nelle caverne si nascondono barche, si seppelliscono poeti, si fanno riti della fertilità e contrabbando, si parcheggia e si sversano auto rubate o usate insieme a spazzature. C’è molta vita nella terza città, quella che non ha né cielo né mare ma molte strade e tante diverse case. Dal sottosuolo napoletano provenivano tutte le acque medicali della città vendute ad ogni angolo di piazza…
A un certo punto scrivi che la città non si presta a una descrizione esclusivamente orizzontale o verticale, ma piuttosto a narrazioni concave e convesse, insomma una forma non euclidea. Mi potresti spiegare meglio, in particolare rispetto alla questione degli “strati di Napoli”?
Si possono fare molti attraversamenti di Napoli: andare da un punto a un altro in orizzontale o dal mare alla collina, da un museo a una chiesa, percorrere i decumani che tagliano il centro antico, scendere nel sottosuolo e percorrerlo. La città si può guardare dall’alto, si può guardare dal mare, si può guardare dal basso e dall’interno: ma la verità è che la città, spesso definita verticale (e porosa da Walter Benjamin), è in realtà una città composta di strati discontinui, di improvvise aperture, di salti indietro, di precipizi, di voli. Davvero appartiene alle geometrie escheriane, decisamente non euclidee. Non è difficile che le rette parallele a Napoli si incontrino, sia nell’architettura, sia nel tempo che scorre in modo inatteso.
Dal sottosuolo alle nuvole tutte le epoche sono ammucchiate per strati: niente è stato raso al suolo, tutto è stato inglobato, nessuno è davvero mai completamente scomparso. In una casa che insiste sull’anfiteatro romano che è dentro l’Anticaglia la cucina si affaccia sui vomitori che portano alla scena, la sala da pranzo ha soffitti affrescati secenteschi e in un muro della camera da letto è nascosta un’antica sepoltura infantile d’epoca ducale, ovvero bizantina. E questo è un esempio qualsiasi, comune nel centro antico.
Ogni strato ne incontra altri, si mescola e si compromette: e questo continua ad accadere anche nelle persone, nelle loro vite, nelle abitudini quotidiane.
Oltre alla città con i suoi quartieri ci sono però anche delle isole. Penso a Nisida. Che cosa ti piace di questo luogo e cosa ti ha colpito della sua storia “mitologica”?
Nisida è uno scoglio assai vicino alla terraferma, al punto che dagli anni Trenta del Novecento una strada la congiunge alla città: oggi ospita un tristemente noto carcere minorile, che ha ispirato film e romanzi e canzoni, ma è stato anche villa romana – la dimora di Bruto, pare – e castello angioino, covo di pirati e carcere murattiano. Ma prima ancora, secondo Victor Bèrard, è stata la casa di Polifemo o forse il sasso che Polifemo scaglia da Posillipo contro Ulisse e la sua nave. Lo scoglio intermedio fra Nisida e la terraferma, ora coperto dalla strada, detto Chiuppino, ha ospitato un lazzaretto durante la grande peste del 1656, è stato cioè un Purgatorio, come si chiamavano a quei tempi. Da Nisida nel sesto secolo parte un piccolo abate africano, Adriano, per Lindisfarne, isoletta vicina alla terraferma inglese, e diventare vescovo di Canterbury. Nisida guarda i resti dell’ex Italsider oggi Città della Scienza e il quartiere, un tempo operaio, di Bagnoli. Non c’è luogo, forse, dove tutti i tempi della città e le sue contraddizioni siano più messe a nudo, questa volta non nella penombra della pietra ma alla luce e sul profilo del mare, sul cui orizzonte scorrono come sipari azzurri da un lato Pozzuoli, capo Miseno, Monte di Procida, Procida, Vivara, Ischia, Capri, dall’altro il Vesuvio e la costiera sorrentina. Nisida rimane agli abitanti ignota, a causa delle restrizioni del carcere, con un lato offerto al mare che, se non lo si osserva in barca, è come il lato oscuro della Luna. Un carcere pieno di ragazzi senza nome, che è anche un sasso lanciato contro Nessuno, come Ulisse dice di chiamarsi a Polifemo, è una suggestione infinita, un ponte fra millenni, lingue, storie, fra la vita e la morte.
É molto curiosa la parte conclusiva dove racconti di Giorgio Manganelli e della sua fuga da Napoli. Perché ci sono città che ci rispecchiano e quindi ci fanno paura perché non vorremmo vederci. Tu di quale città hai paura e in che cosa ti rispecchi invece in Napoli?
Napoli è una città che incute paura, malfamata dai tempi dei romani, ritratta da Boccaccio e da Petrarca, è la città dove Andreuccio ingannato finisce in una fogna e in una tomba: non può stupire se Manganelli ne rimase spaventato. Città esagerata, lussuriosa, goduriosa, “cannaruta”, ovvero golosa e famelica, violenta e passionale, carnale proprio come la scrittura di Manganelli, combinatoria e infera… A me spaventano le città troppo nuove, troppo schematiche, senza storia, senza antichità. Detesto il vuoto emotivo che si finge funzionale e in realtà costruisce anonimi lager. Dunque evito le città nate troppo di recente o troppo ricostruite. Napoli, che conserva tutto, invecchia e rinasce dalle proprie ceneri mi risponde anche quando mi divora…
Qual è uno dei tuoi luoghi preferiti di Napoli?
Molti di quelli raccontati ne Il sole non bagna Napoli sono luoghi preferiti. In assoluto torno con gioia al Castello aragonese di Baia, dove mie storie sono nate. E al fico capovolto nelle antiche terme di Baia, che è un luogo dove la magia è palpabile, dove ci si ricarica. Lo stesso vale per Cuma e per la sua abbandonata Foresta. In città sono felice camminando fra i Decumani come affacciata sul mare da Posillipo o sotto i palazzi liberty di Chiaia: la città ha continui luoghi di meraviglia. Da pochi mesi nel bosco di Capodimonte è stato aperto il Giardino Torre che in questo libro non ha fatto in tempo a entrare: ecco un nuovo spazio che può diventare un luogo preferito…
Antonella Cilento
ANTONELLA CILENTO (Napoli, 1970) insegna scrittura creativa dal 1993, ha fondato e dirige da trent’anni Lalineascritta Laboratori di Scrittura. Dal 2018 coordina e insegna nel primo master di scrittura e editoria del Sud Italia, SEMA. È uscito per Bompiani nel 2021 La caffettiera di carta. Inventare, trasfigurare, narrare: un manuale di lettura e scrittura creativa, intenso racconto del suo lavoro di maieuta. Dirige da quattordici anni la rassegna di letteratura internazionale STRANE COPPIE. Ha scritto per la radio, il cinema e il teatro, è stata segnalata agli esordi dal premio Calvino e ha vinto il premio Tondelli con la sua tesi di laurea. Con Lisario o il piacere infinito delle donne (Mondadori, 2014, tradotto in molti paesi) è stata finalista al premio Strega 2014 e vincitrice del premio Boccaccio 2014. Fra gli ultimi libri: Bestiario napoletano (Laterza, 2015), La madonna dei mandarini (NN editore, 2015), Morfisa o l’acqua che dorme (Mondadori, 2018). Nel 2022 è uscito Solo di uomini il bosco può morire per Aboca edizioni. Attualmente collabora con “la Repubblica – Napoli” e con “Donne Chiesa Mondo”.
Questa è la città dove ai bambini poveri per due secoli si insegna a suonare perché allietino la morte dei vecchi ricchi o dove i bambini si castrano perché cantino, soavi come angeli, nelle cappelle e nei teatri o dove le bambine e i bambini si vendono, in cambio del pane, ai soldati americani, dove i bambini sparano o sono sparati. Questa è la città dove i ragazzi si ammazzano fra loro, dove un giovanissimo ladro di Rolex spara tre colpi in petto a un giovane musicista e va a giocare a carte. Ossa e angeli, morte e vita, eros e thanatos, come se piovesse. Il sole non bagna Napoli, Antonella Cilento
Un reportage narrativo sulla città più raccontata e chiacchierata al mondo: dal momentaneo buio di un distacco di retina, Antonella Cilento entra nelle ombre di una città dove tanto il sole quanto il mare sono apparenze esterne. Napoli, attraversata dal centro alle periferie e lungo i suoi innumerevoli strati temporali, riappare da parole di scrittrici e scrittori, da Felix Hartlaub a Fabrizia Ramondino, da E.T.A. Hoffmann a Eduardo De Filippo, da Giuseppe Montesano ad Anna Maria Ortese e molti altri.
Mappe, decumani, specchi, giardini pensili, pavimenti, maghe, picari e madonne ricompongono un puzzle vivente di una creatura, forse femmina, molto antica, sfuggente e notturna: è fatta di carta, è solo immaginaria?
Con gli occhi chiusi o al sole, da lontano e da vicino, Napoli sorprende e cattura, qualche volta inganna.